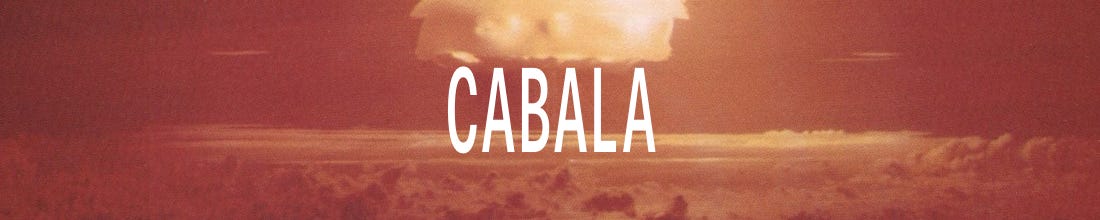MITZPE
di Matteo De Giuli. In questo numero leggerete di astronauti e spine dorsali, di Marte e Chardonnay, di archivi e bombe nucleari, asini selvatici e salti nel vuoto.
Benvenuti, questo è il numero centosei di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.
MEDUSA è una newsletter che parla di cambiamenti climatici e culturali. Ogni due mercoledì. Come forse avete notato, anche qui dentro sono cambiate un paio di cose. Prima di tutto, abbiamo cambiato la piattaforma su cui ospitare la nostra newsletter. Abbiamo cercato di mantenere il nostro abito, approfittando della novità per giocare un po’ con la grafica. Poi: rivisitando il nostro percorso, abbiamo pensato che fosse ormai tempo di ridefinire la nostra ragione d’essere, semplificandola. MEDUSA è una newsletter, il posto che abbiamo costruito per scrivere e sentirci liberi, la scatola cosmica che ci permette di sperimentare e di andare nelle direzioni che preferiamo. Un oggetto semplice, che ci ha permesso e ci permetterà di sondare altri linguaggi: non solo articoli e racconti, ma anche audio, video, mostre, ibridi vari.
“Storie dalla fine del mondo”, il sottotitolo della newsletter, era la nostra idea poetica di una verità geologica, l'Antropocene: abbiamo deciso di lasciarlo al nostro primo libro, che si intitola MEDUSA. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo). Da oggi qui saremo solo MEDUSA newsletter.
Un’ultima notizia: tutto quello che scriviamo su MEDUSA, ogni due settimane, resta gratuito per tutti. Da oggi, però, se ti piace quello che facciamo, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si iscrive scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Potete aggiornare la vostra iscrizione qui:
Per tutto il resto, la nostra homepage è ora medusanewsletter.substack.com. Siamo contenti di rivederci qui, e vi ringraziamo.
Di solito la newsletter è divisa in tre parti: un articolo inedito e due rubriche, i link e i frammenti di testo dei Cubetti, e i numeri della Cabala. Per il resto, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.
In questo numero leggerete di astronauti e spine dorsali, di Marte e Chardonnay, di archivi e bombe nucleari, asini selvatici e salti nel vuoto.
La notte non è mai buia, e anche sulle strade senza lampioni riverbera una luce cinerea e bluastra, come se la Luna fosse grande il doppio o due volte più vicina. Durante il giorno il panorama è indistinguibile dalle foto di Marte; pietre rosse, arancioni e ocra fino all'orizzonte.
Mitzpe Ramon è una città di cinquemila abitanti, un centinaio di prefabbricati, capannoni e edifici bassi nel deserto del Negev. Si affaccia sul ciglio di uno strapiombo di centinaia di metri. Lì inizia il cratere Makhtesh Ramon, una valle lunga quaranta chilometri e larga otto di cui è impossibile abbracciare i confini con lo sguardo. Sembra l’impronta lasciata da un immenso asteroide ma è una depressione naturale che si è formata grazie al peso del tempo, quando l’oceano ha lasciato spazio al deserto e il terreno ha iniziato a collassare su se stesso solo poco alla volta, roccia dura che preme su minerali morbidi per milioni di anni.
Lungo la linea che separa Mitzpe Ramon da un salto nel vuoto non c’è neanche uno steccato. Una persona molto distratta potrebbe semplicemente precipitare giù durante una passeggiata. Ma gli esseri umani che si avvicinano all’orlo sono pochi, ci si avventurano invece con più disinvoltura decine di stambecchi selvatici, che non è raro sentire zoccolare anche per le vie più centrali della città. I maschi hanno delle corna minacciose, semicerchi lunghi un metro decorati da nodi e rigonfiamenti che ricordano le vertebre della spina dorsale. Al tramonto i più spavaldi si fanno largo tra i tavolini dei pochi bar della città per rovistare tra i cestini.
Dicembre e gennaio sono i mesi peggiori per i turisti, il cielo è spesso coperto e le temperature di notte scendono anche decine di gradi sotto lo zero. Io arrivo in una sera dei primi di gennaio, e lo stupore per il luccichio argenteo della Luna non riesce a ricompensarmi dal freddo che mi aggredisce appena scendo dall’autobus. L’ostello è essenziale ma non sgradevole, pulito e sobrio, più o meno gli stessi aggettivi che potrei utilizzare per descrivere Yotam, il ragazzo che mi accoglie alla reception. È vestito da montagna, con i pantaloni pesanti e un maglione di pile di una taglia più grande della sua. Mi chiede da quale tappa del viaggio vengo e rispondo solo Gerusalemme senza aggiungere che sono stato tre giorni in Palestina. Oltre a lavorare per l’ostello, Yotam ha un terreno, poco fuori il centro abitato, dove alleva alpaca, lama e una razza locale di asini selvatici che chiama asiatic wild ass. Mi dice che il giorno dopo ha mezza giornata libera e se voglio mi può scarrozzare un po’ in giro.
La mattina mi sveglio presto e prima di incontrare Yotam mi incammino per la città, inizio a spiare dentro ai negozi. Incontro: un discount, un negozio di abbigliamento sportivo; ristoranti, di cui uno indiano, uno messicano, uno caucasico e tre vegani; un supermarket bio, un supermarket per animali domestici, un piccolo mcdonalds, due palestre di yoga; le indicazioni per raggiungere un albergo di lusso con piscina e una decina di centri turistici che organizzano “esperienze uniche” nel deserto. Passo accanto a queste vetrine estranee e familiari durante una mattinata nuvolosa. Cerco di buttare un occhio anche dentro alle finestrelle che si aprono sulle facciate pallide delle abitazioni private ma non riesco a scorgere nessun dettaglio interessante delle stanze. Le strade sono ampie, l’asfalto è un po’ sconnesso. Tra gli edifici c'è qualche albero a basso fusto e dell’erba stenta.
Da qualsiasi punto della città, si vede la possente torre idrica comunale. È in cemento armato, con la testa a cono rovesciato. Per austerità e robustezza potrebbe essere stata catapultata lì dall'Unione Sovietica. Questa sensazione di leggera ucronia è rafforzata dalle scritte in cirillico che appaiono a macchia sui cartelli per strada, cosa non rara in Israele dove il russo è la lingua madre non ufficiale più diffusa.
L’altro edificio degno di nota, che spezza la monotonia urbanistica di Mitzpe Ramon e intensifica l’atmosfera extraterrestre, è il Visitor Center costruito a pochi passi dal dirupo del cratere. Ha la forma di un verme schiacciato che si attorciglia su se stesso. Si affaccia sul makhtesh con una grande vetrata curva che ricorda la visiera di un casco da astronauta. Mitzpe d’altra parte significa “punto di osservazione”. È un edificio bizzarro, ma messo lì, appena fuori dal centro abitato, in contrasto allo schema ortogonale delle case tutte uguali colpisce come un capolavoro dimenticato di Frank Lloyd Wright.
Per entrare al Visitor Center devo schivare l’interesse inquieto di un gruppo di stambecchi che bivacca nei dintorni. All’ingresso, come se mi si rivelasse la parte più evidente di un mistero ostinato, scopro che quell’edificio, oltre a essere una sorta di pro-loco, è anche un piccolo museo dell'astronautica dedicato a Ilan Ramon, colonnello dell'aviazione israeliana, il primo ebreo a volare nello spazio, morto il primo febbraio 2003 nell'incidente dello Shuttle Columbia dopo una missione spaziale di due settimane. Nato con il nome di Ilan Wolferman, all'inizio della carriera militare, prima ancora di diventare astronauta, lo cambiò in Ramon proprio per rendere omaggio a quel pezzo alieno di deserto.
In Israele sorti ostili e memorie inconciliabili si trovano a dover sopravvivere convivendo, e così per un museo che celebra un eroe nazionale ce n’è probabilmente un altro che chiede di raccontare una storia differente. Non fatico a scoprire che quella di Ilan Ramon è una figura dibattuta, anche se di questo nei pannelli del Visitor Center non c'è traccia. Nei suoi anni di aviazione militare prese parte alla prima guerra in Libano, bombardando la popolazione civile, e partecipò all'attacco aereo del 1981 sul reattore nucleare di Osirak in Iraq.
L'esposizione museale è spoglia e tristarella, ci sono delle teche che conservano le tute pressurizzate usate da Ramon, molte foto e qualche modellino di sonda spaziale. Una stanza del museo è dedicata poi alla storia geologica unica della zona: tre campioni di roccia – arenaria, calcare e granite – sono esposti sotto una teca di plexiglass. Su un pannello leggo che, grazie alle sue condizioni meteo e alla conformazione del terreno, Mitzpe Ramon è stata effettivamente scelta dall'agenzia spaziale israeliana per simulare missioni umane su Marte. I partecipanti faranno piccoli esperimenti, raccoglieranno dati sui rischi di contaminazione biologica e i loro comportamenti saranno studiati per testare la tenuta psicologica di un gruppo di persone in condizioni di isolamento quasi assoluto.
Torno all’ostello per incontrare Yotam. Lo trovo che mi aspetta al volante di una jeep. Mi racconta che con quella, in alta stagione, porta i turisti in giro per il deserto. È il suo terzo lavoro, se non ho perso il conto, e il numero è destinato subito ad aumentare: da qualche mese per due o tre giorni alla settimana aiuta anche un amico nella sua azienda vinicola. È lì che stiamo andando.
Mi chiedo che cosa significhi per lui essere nato e vivere in questo avamposto della civiltà ricco ma desolato, tra le rocce e gli stambecchi, dove le case sono cubi e parallelepipedi bianchi di uno, due o tre piani. L’effetto che fa a chi la visita è che Mitzpe Ramon non sia mai riuscita a diventare una città, che sia rimasta un insediamento. Il suo spirito è ancora quello della fondazione, negli anni Cinquanta, quando in mezzo al nulla furono costruite lì le prime case di un campo operaio, durante i lavori per la strada statale che porta al mar Rosso. Oggi, vista da lontano, non può che far pensare a una colonia umana in un pianeta ostile. Vorrei dirlo a Yotam, ma decido che in fondo la musica nella jeep è troppo alta e il mio inglese troppo pigro perché io possa parlare di “coloni” con un ragazzo israeliano senza essere sicuro che questo non porti a una sciarada di fraintendimenti. Sto zitto e guardo fuori, finché non arriviamo.
Dal punto di vista meteorologico questa terra è un disastro, mi dice Yotam, l’aria è secca, d’estate fa un caldo infernale, tutto l’anno non piove quasi mai e quel poco che piove non resta perché viene spazzato via nelle inondazioni lampo tipiche del Negev che trascinano giù a valle fiumi di fango. Ma proprio per queste caratteristiche Mitzpe Ramon è diventato un laboratorio. Il futuro del pianeta è Mitzpe, mi dice. L'azienda vinicola del suo amico, che fa parte di una rete di vigneti costruiti in zona, è una surreale vivace macchia verde in mezzo ai colori pallidi del deserto. I filari delle viti mi sembrano troppo esigui per ricavare un numero dignitoso di bottiglie, e Yotam mi spiega che in effetti quelle aziende sono utilizzate soprattutto come luoghi di sperimentazione per capire come l’uva possa crescere in condizioni estreme. In fondo tra non molto anche le campagne italiane e francesi potrebbero ritrovarsi immerse in un clima simile a quello del Negev. Così queste imprese si sostengono grazie ai finanziamenti delle università, delle grandi aziende vinicole europee e dalle società di irrigazione che stanno testando lì le loro tecnologie.
Yotam si avventura in molti dettagli tecnici, e io che sono in vacanza non ho intenzione di seguirli. Li dimentico subito ma provo a ricostruirli: con il caldo l’uva va a maturazione più velocemente, e questo scombina ovviamente l'intera filiera, i vini diventano più zuccherosi e troppo poco acidi, escono fuori con colori sbagliati e soprattutto degradano in sapore e gradazione alcolica. Ma, aggiunge Yotam, adesso, dopo anni di duro lavoro, stanno riuscendo a ottenere, e addirittura mettere in commercio, le prime bottiglie buone. Anche nel deserto, anche in queste condizioni climatiche.
Mi fa assaggiare il loro Chardonnay, senza però versarsene anche lui un goccio. È troppo presto di mattina ma non posso rifiutare. Per quello che ne capisco mi sembra un vino terribile, molto intenso e terroso, minerale, troppo alcolico. Mi dà subito alla testa. This is future that awaits us all, mi dice Yotam con un tono di voce indecifrabile. Cerco di sorridere e finisco il bicchiere.
#1 DOV’È L’ARCHIVIO
I più attenti avranno notato che con il cambio di piattaforma si è perso l’archivio degli utlimi numeri. Da qui in poi, però, su medusanewsletter.substack.com troverete tutti i nuovi episodi. Per chi volesse recuperare le nostre vecchie cose, alcuni estratti della newsletter sono stati pubblicati in questi anni sul sito di Not (qui quelle scritte da Matteo, qui quelle scritte da Nicolò). Altri frammenti delle vecchie MEDUSE sono finiti nel nostro libro. Ci sono invece numeri del passato che rimarranno in giro in un posto indefinito dell’etere. Magari ne rispolvereremo qualcuno come contenuto extra per gli abbonati.
#2 SE SAI COME FARLO
Il problema dell’emergenza climatica si trascina conseguenze pratiche, di sopravvivenza, che colpiscono soprattutto le persone abbandonate in difficoltà, cioè povere, che vivono in realtà povere, sfruttate. Per quanto riguarda gli aspetti psicologici della questione invece, non per forza connessi agli effetti materiali della crisi, a soffrire di angoscia e depressione è una fetta di popolazione che sembra prescindere dal genere, dalla classe sociale, dall’età.
Almeno, questa sembra la tesi di un reportage pubblicato qualche settimana fa dal New York Times, “Climate Change Enters the Therapy Room”. I protagonisti del pezzo rappresentano diverse generazioni: c’è la madre di famiglia, il nonno, la diciottenne. A unirli, aggiungiamo noi, è un certo livello di istruzione che forse li aiuta a deprimersi. La consapevolezza dell’emergenza climatica, e il suo ruminare, possono portare a una patologizzazione della sofferenza psichica. Quali possono essere i primi segnali? Attacchi di panico e oppressioni toraciche, l’impossibilità di proiettare il pensiero nel futuro, moti di rabbia e alienazione verso chi sembra “vivere come niente fosse”. Se provi alcune di queste sensazioni, non sei sola: sempre meno, anzi, al punto che si stanno sviluppando dei nuovi campi di ricerca negli studi psicologici.
Anche se ci sono pochi dati empirici sui trattamenti efficaci, il campo si sta espandendo rapidamente. La Climate Psychology Alliance fornisce un elenco online di terapeuti consapevoli del clima; la Good Grief Network, una rete di supporto tra pari modellata sui programmi di dipendenza in 12 passi, ha generato più di 50 gruppi; cominciano a comparire programmi di certificazione professionale in psicologia del clima.
E niente porta a escludere che realtà del genere possano comparire nel nostro Paese. Per quanto agli albori, si tratta però già di una novità problematica: tra gli esperti ci sono dei dubbi rispetto a questo presunto ingresso delle opinioni nel rapporto di cura; c’è chi non si mostra convinto rispetto a una presunta diversità clinica tra l’ansia climatica e un’ansia sociale più generalizzata (terrorrismo o quant'altro). Alcuni attivisti invece, aggiunge Ellen Barry, temono che l’ansia climatica possa essere scambiata per un pensiero disfunzionale, qualcosa da tacere, e che invece andrebbe urlato.
“Ma la signora Black non era interessata ad argomenti teorici; aveva bisogno di aiuto subito”. E lo trova, racconta l’autrice, nella terapia offerta dal Dr Doherty. Doherty, oltre all’ascolto, offre ai suoi pazienti delle riflessioni che non escono dal Problema, nel tentativo di alleviarne la condizione.
Il dottor Doherty ascoltò [la signora Black] in silenzio. Poi le disse, scegliendo attentamente le parole, che il tasso di cambiamento climatico suggerito dai dati non era così drastico come quello che lei stava immaginando. "Nel futuro, anche con gli scenari peggiori, ci saranno giorni buoni", le disse, affidandosi ai suoi appunti. "Le catastrofi accadranno. Ma, in tutto il mondo, ci saranno giorni buoni. Anche i vostri figli avranno giorni buoni". A questo punto, la signora Black ha cominciato a piangere.
Nell’articolo viene citato al volo un libro di Viktor E. Frankl, L’uomo in cerca di senso, quel Frankl che potrebbe risuonare in tempi pandemici, dove tutti i bisogni materiali della maggioranza, quelli alla base della piramide di Maslow, sono più o meno soddisfatti, ma è sempre più incipiente il vuoto in cima, dove per Maslow starebbe il benessere psicologico. Sopravvissuto a quattro campi di sterminio, Frankl scrisse a Maslow che anche in mancanza di pane il bisogno più urgente può diventare la volontà di significato. Un bisogno indipendente dagli altri, interclasse, intergenerazionale, oggi si direbbe intersezionale. La consapevolezza, citando quella battuta, è la causa e la soluzione dei nostri problemi.
#3 WASTEOCENE
Soltanto scrivere “Antropocene”, quando abbiamo aperto la newsletter, rientrava in una piccola forma d’azzardo; era un concetto noto nei climate studies, nel mondo dell’arte, ma lontano da essere uno strumento alla portata di tutti. In questi anni forse non è diventato pienamente mainstream, ma ha avuto comunque molto successo e potremmo dire che è uno dei termini che ha contribuito alla nascita di una nuova consapevolezza ecologica. Nel frattempo, come abbiamo raccontato già diverse volte, è stato però anche a lungo discusso, attaccato, ripensato. C’è chi ha proposto di sostituirlo con Capitalocene, Plantationecene, Chthulucene, Anthrobscene, Misanthropocene… Negli anni i nuovi -cene si sono moltiplicati in una lotta di narrazioni forse troppo settoriale che, insieme all'abuso del termine Antropocene, rischia di far perdere interesse all’intera faccenda. Anche per questo, però, vale la pena prestare particolare attenzione ai rari casi in cui la nascita di un nuovo -cene nasconde uno sforzo genuino di illuminare qualche aspetto poco raccontato del presente. E ci sembra che questo sia il caso di “Wasteocene”, l’era degli scarti, termine proposto dallo storico dell’ambiente Marco Armiero. Anche se magari non è un vocabolo che avrà la forza di affermarsi nel dibattito, porta con sé un racconto del mondo che merita di essere ascoltato. Citiamo da una intervista che gli ha fatto Stefano Dalla Casa:
Più che degli scarti intesi come rifiuti in senso letterale (che sono un problema enorme) secondo Armiero il Wasteocene è l’era delle relazioni di scarto (wasting relationship), cioè i processi che scartano sistematicamente anche gli esseri viventi, umani e non umani, i luoghi, i saperi e persino i ricordi.
Il libro-manifesto di Armiero, L’era degli scarti, è uscito qualche mese fa per Einaudi. Il resto dell’intervista che gli ha fatto Dalla Casa è sul Tascabile.
#4 COLLETTANEE
Sono passati ormai 10 anni: nel giugno del 2012 a Kassel inaugurava la tredicesima edizione di documenta – una delle più note e prestigiose manifestazioni internazionali d'arte contemporanea in Europa – con la direzione artistica di Carolyn Christov-Bakargiev. Le opere ospitate ruotavano attorno a questioni ambientali e di crisi ecologica: ruotavano attorno all’Antropocene e l’impatto dell’essere umano sul pianeta. Fu quello uno dei contesti in cui ci si ritrovò anche a ricalibrare il dibattito ecologista che seguì negli anni. dOCUMENTA(13) - ten years later è il nuovo archivio digitale che in questi mesi ricorderà quella manifestazione; è ospitato sul sito del Castello di Rivoli, diretto oggi da Carolyn Christov-Bakargiev.
Sono passati invece meno di 10 giorni dall’uscita di una raccolta di cui torneremo presto a parlare: I racconti dell’apocalisse. È stata pubblicata dal Saggiatore e l’ha curata Andrea Esposito. Contiene racconti, testi e frammenti di romanzi, nomi obbligati e altri inattesi, selezionati, connessi tra loro e introdotti da Esposito: H. G. Wells, Leopoldo Lugones, Secondo Lorenzini, Snorri Sturluson, Massimo Bontempelli, Frank L. Pollock, Aleksandr Puškin, Robert Barrr, Amando Nervo, H.P. Lovecraft, Giacomo Leopardi, Nathaniel Hawthorne, Gustav Meyrink, Jack London, George C. Wallis, Begum Rokeya Sakhawat Hossain, Ildegarda di Bingen, Mary Shelley, Jules Verne, M.P. Shiel, George Gordon Byron, Edgar Allan Poe, Sara Teasdale, Robert Walser.
01/03/1954: gli Stati Uniti testano “Castle Bravo”, ovvero quella che è passata alla storia come la quinta bomba nucleare più potente di sempre. Il laboratorio designato per questo esperimento è l’atollo Bikini, nelle isole Marshall, nel Pacifico.
L’altezza del fungo atomico arrivò a 40 chilometri. Circa 100 volte l’altezza dell’Empire State Building. Il diametro toccò i 100 chilometri.
A causa delle radiazioni, sulle isole iniziarono a registrarsi un numero eccezionale di patologie tumorali. 1/3 della popolazione si trasferì in Arkansas, dove trovò impiego negli allevamenti.
Oggi il 3% della popolazione dell’Arkansas nordoccidentale è composta da persone provenienti dalle Marshall. Da quando è iniziata la pandemia, gli operai avicoli provenienti dalle Marshall morti per COVID-19 sono pari al 50% delle vittime di tutto lo Stato.
Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 421,29 ppm
(parti per milione) di CO2.