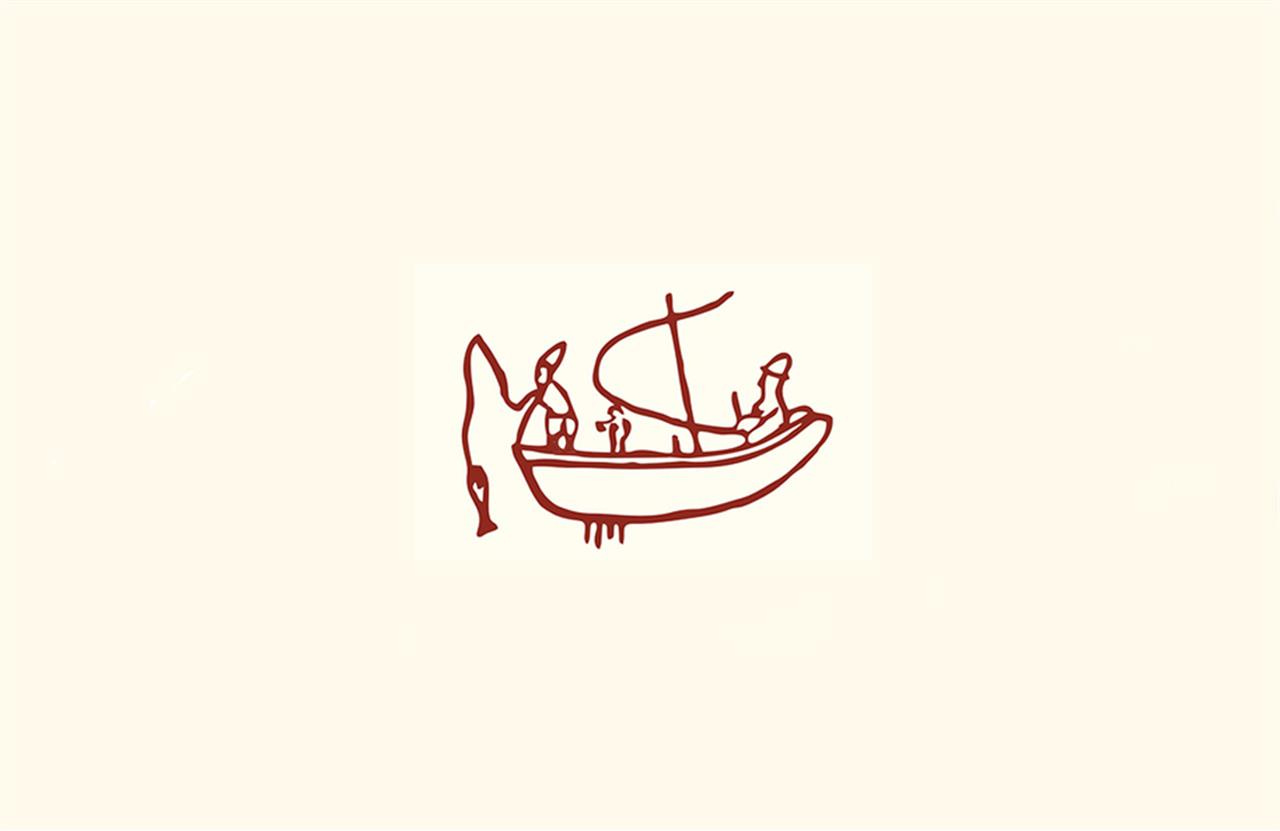AUTOBIOUCRONIA
di Carlo Mazza Galanti. In questo numero leggerete di Carrère e Cleopatra, di avversari e tramaglini, di yoga e Fuji, di vite che non sono la nostra.
Benvenuti, questo è il numero centosettanta di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.
MEDUSA parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Ogni due mercoledì.
Quello che scriviamo su MEDUSA è gratuito per tutti. E senza sponsor. Se ti piace quello che facciamo, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si abbona scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Se siete già iscritti, potete aggiornare il vostro abbonamento qui:
MEDUSA newsletter è un animale strano: può contenere un articolo o un racconto inedito, una lunga intervista oppure una serie di frammenti, storie più brevi, appunti di lettura, link o altre segnalazioni.
In questo numero siamo felici di ospitare un pezzo di Carlo Mazza Galanti, traduttore, critico letterario e giornalista culturale.
In chiusura l’unica certezza: i numeri della CABALA.
Per il resto, la nostra homepage è medusanewsletter.substack.com, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.
In questo numero leggerete di avversari e tramaglini, di yoga e Fuji, di vite che non sono la nostra.
Con i se e i con i ma non si fa la Storia, come ben sappiamo: ma si possono fare delle fiction. Intorno alla metà del milleseicento Pascal ne scrisse una brevissima destinata a enorme successo: “Se il naso di Cleopatra fosse stato più corto tutta la faccia della terra sarebbe cambiata”. Nel 1876 un letterato francese, Charles Renouvier, inventò un nome per questo genere di invenzioni storiografiche - ucronia - una parola capace di coniugare carattere derivativo (è ricalcata sull'Utopia di Thomas Moore), originalità e una qualche eleganza, e che perciò è diventata una etichetta di genere e si usa oggi con una certa frequenza. Un secolo dopo, un terzo scrittore francese, Emmanuel Carrère, ha pubblicato un saggio dedicato all'ucronia e l'ha fatto, come al solito, a modo suo.
Verso la fine del libro, oggi riproposto proprio con il titolo di Ucronia da Adelphi (nella traduzione di Giuseppe Girimonti Greco e Federico Di Lella), l'autore ci lascia intendere la ragione del suo interesse. Come a ribadire il monito degli storici sui passati alternativi, Carrère sembra relegare il genere al rango dei divertimenti oziosi e tutto sommato inutili. Tuttavia, aggiunge:
Ci resta la possibilità di scrivere le nostre memorie, edizioni al tempo stesso espurgate e ampliate delle nostre vite, in cui mettiamo in mostra noi stessi per come avremmo dovuto essere e non per come siamo stati, grazie all'insignificante miracolo di un piccolo editing interiore.
Che le ultime pagine di questo saggio riconducano le precedenti teorizzazioni a una questione squisitamente privata non è così sorprendente, almeno per chi conosce il narcisismo programmatico di Carrère. All'altezza di questo libretto (la nota finale è datata 1980-1985) lo scrittore francese non solo non aveva mai pubblicato ucronie (né mai l'avrebbe fatto) ma neppure aveva pubblicato i libri che l'avrebbero reso il Carrère che tutti conosciamo. All'epoca era ancora impegnato nell'ideazione di romanzi di finzione più o meno classici come I baffi o L'Amie du jaguar, comunque esenti dalle caratteristiche (oggi diremmo) “autofinzionali” che gli avrebbero regalato tanta fama. In qualche maniera, però, il cuore, o il midollo, dello scrittore era già tutto lì, dentro al suo saggio giovanile.
È forte, insomma, la tentazione di sviluppare, con il senno di poi, l'ipotesi autobiografica, e rileggere così il brillante esercizio di critica letteraria di questo libro come una prefigurazione della poetica e dei libri di Carrère a venire. Si potrebbe immaginarla come una specie di recensione ucronica. Ma prima di passare a questo livello più subliminale conviene spendere qualche riga sul contenuto esplicito del saggio: l'ucronia in senso stretto.
Ucronista è colui che narra avvenimenti storici diversi da quelli realmente accaduti basandosi su un'ipotesi controfattuale (“cosa sarebbe successo se...”). Per farlo è necessario selezionare un evento passato carico di potenzialità, un punto particolarmente sensibile della storia umana e da lì imboccare la diramazione temporale alternativa a quella reale, e poi seguirne lo sviluppo nel futuro.
L'ucronista può dunque muoversi tra la tranciante semplicità aforistica del succitato Pascal e le complesse costruzioni narrative di un Philip K. Dick. La svastica sul sole, il capolavoro dello scrittore statunitense, articola nel modo dickiano un topos della narrativa controfattuale: come sarebbe oggi il mondo se i nazisti e i giapponesi avessero vinto la seconda guerra mondiale? A complicare le cose, all'interno dell'universo del libro, circola un romanzo in cui l'autore immagina, specularmente, come sarebbe il mondo se avessero invece vinto gli alleati. Ma lo sviluppo del genere potrebbe allargarsi, in tempi più recenti, alle vertiginose speculazioni narrative sugli universi paralleli che tanto spazio hanno trovato nel narrativa e nella cinematografia anche mainstream, facendo incetta di Oscar con una pellicola come Everything everywhere all at once - o vincendo il più importante premio letterario francese, con L'anomalia di Hervé Le Tellier.
Veniamo al saggio. Va detto che il corpus bibliografico utilizzato da Carrère in questo libro è piuttosto esiguo e molto francocentrico. Il discorso si dipana intorno a testi che quasi nessuno conosce fuori dall'esagono (e anche, suppongo, all'interno) come Napoleone apocrifo. Storia della conquista del mondo e della monarchia universale. 1812-1832 dove l'autore ottocentesco Napoléon Geoffroy-Chateau immagina che l'imperatore dei francesi, non essendo stato sconfitto a Waterloo, sia riuscito a estendere il suo dominio su buona parte del mondo. Oppure l'eponima Ucronia di Renouvier, dove l'autore specula intorno a un universo in cui la chiesa cattolica non sarebbe riuscita a istituzionalizzare la fede cristiana trasformandola in un vasto sistema di potere. O ancora, sulla stessa linea ma più radicale, il Ponzio Pilato di Roger Caillois (unico dei tre citati ancora letto e disponibile sul mercato, in Italia, per i tipi di Sellerio), in cui s'immagina che, avendo Pilato deciso di salvare Gesù, il cristianesimo non sia mai esistito. Notiamo di passaggio come gli ultimi due libri siano stati scritti non da romanzieri ma da pensatori e filosofi, ribadendo il carattere fortemente speculativo del genere ucronico.
La speculazione non manca naturalmente nel libro di Carrère, dove il giovane saggista si diletta a esplicitare le questioni teoriche tra cui si dibattono gli “ucronisti”: cos'è la Storia, esiste un determinismo storico, esiste il libero arbitrio, quanto contano i singoli personaggi o i singoli avvenimenti nello sviluppo delle civiltà, eccetera… Carrère articola questi dilemmi quasi malvolentieri, come se dietro alla fredda gabbia della teoria (all'origine di questo volume c'era una tesi di laurea) affiorasse un interesse più segreto, più idiosincratico, quello appunto dichiarato nelle ultimissime righe: deviare dalla critica letteraria alla sfera morale, o esistenziale, fregandosene della coerenza disciplinare e cercando nell'ucronia qualcosa che va ben oltre la definizione di un preciso genere artistico.
Spia di questa tendenza è fin dalle prime battute l'ipotesi massimalista che “qualsiasi opera di finzione, a meno che non sia ambientata nel futuro, modifichi in un modo o nell'altro il passato”, e che quindi in quanto tale possa considerarsi ucronica. Fabrizio del Dongo o Renzo Tramaglino non sono mai esistiti.
Seguendo questa traccia, emerge a sprazzi un profilo dell'ucronista come letterato simil-manganelliano, sublime mistificatore in rotta con la realtà, qualcuno che si trova “solo contro tutti”: un truffatore insomma, un impostore che in nome del desiderio, o del rimpianto, decide di riscrivere il passato ricreandolo secondo i propri capricci, le proprie velleità, e poco importa se per farlo dovrà ricorrere alle più spudorate falsificazioni. Quello che conta è l'ebbrezza, il senso di potere che deriva dalla sensazione di liberarsi “dall'imponderabile peso della realtà”, rimaneggiando la Storia e infrangendo il tabù entropico, di macbethiana memoria, secondo cui “ciò che è fatto non si può disfare”.
Anche qua la fantascienza più recente avrebbe parecchio da aggiungere, con le sue figure di faustiani navigatori di mondi quantistici e postumani creatori di realtà virtuali capaci di sconfiggere non soltanto il passato ma, se tutto va bene, anche la morte. Si pensi al successo che i viaggi nel tempo “riparatori” hanno avuto nel cinema e nella televisione degli ultimi anni. Blockbuster come Looper e Interstellar o più raffinate serie tv come Devs di Garland, o l'amabile Petite maman di Céline Sciamma: la possibilità di riscrivere il tempo perduto sembra diventata quasi una moda. Ma Ucronia, come si diceva sopra, ha quasi quarant’anni, il filone del cyberspazio e degli universi paralleli all'epoca era sul nascere, e comunque Carrère sembrava più interessato a piegare il senso della sua ricerca verso una direzione intima e, ça va sans dire, autoriferita.
Che significa vivere come se? In un passato apocrifo ma soprattutto in un presente che quel passato inficia? Alla fin fine poco ci importa dell'esito di una battaglia: l'immaginazione dell'ucronista non ha niente di meglio da offrirci della storia reale. Ci affascina di più il romanzo della sua mente.
La mente: una coscienza infelice che fatica a scendere a patti con la propria finitudine. Più che la casualità o il determinismo storico è questo dramma interiore quello che spinge a scrivere Carrère ed è proprio, guarda caso, il dramma che in un modo o nell'altro metterà in scena nelle sue opere migliori.
Un uomo che vive in un passato apocrifo, inventato di sana pianta, e che cerca di convincere tutti della realtà di questa costruzione immaginaria partorita da una frustrazione incommensurabile: non è esattamente il profilo del protagonista di quello che resta forse il libro più riuscito di Carrère, cioè L'avversario (2000)? Ma già ne I baffi (1986) un uomo scopriva o pensava (o segretamente desiderava) di non essere la persona che era: il gesto banale di radersi i baffi scatenava una crisi identitaria, segno esteriore dell'intolleranza per la vita borghese in cui il protagonista si sentiva recluso.
Nel 1993, Carrère s'immerge nella vita e soprattutto nell'opera di Philip K. Dick, producendo una biografia del romanziere americano. L'accento cade inevitabilmente sul tormentato paesaggio interiore del maestro della fantascienza. Nel suo caso la riscrittura del presente assume la forma di una narrazione gnostica: Dick non accetta la realtà così come appare, è convinto di trovarsi coinvolto in un mega-complotto e che il passato non sia quello che crediamo, né di conseguenza il presente.
La delusione che guida lo scrittore di ucronie abita queste finzioni: “l'ucronista continua, come un diavoletto di Cartesio, a correre di qua e di là, attirato dai due poli, la verità che ammette e la fantasia che desidera”, scrive Carrère. Purtroppo, come nota qualche pagina dopo, se certe dittature sono riuscite effettivamente a modificare il passato riscrivendolo da capo, nel caso della storia individuale le cose sono più complesse e correre da una parte all'altra può rivelarsi estremamente problematico.
L'insofferenza per la realtà (e per l'identità che tale realtà impone) sembra guidare le “autobiografie allo specchio” o per interposta persona che rappresentano la parte più recente, e più conosciuta, dell'opera di Carrère. Limonov, indipendentemente dalla realtà del personaggio biografato (alcuni seguaci dello scrittore e militante russo considerano quel libro quasi infamante) rappresenta benissimo l'atteggiamento ambivalente di Carrère verso l'esistenza normie e compitamente borghese che lui stesso, con la sua famiglia eccellente, il suo successo planetario e la misura illuministica della sua scrittura, incarna al massimo grado. Questa volta, l'ucronia (o la l'autobio-ucronia, per inventarci un'etichetta nuova) è costituita dal confronto ravvicinato con la figura di un uomo che agli occhi dell'autore rappresenta l'opposto di se stesso, e quindi il bisogno d'immaginarsi diverso, di essere un altro, di vivere la vita di un altro.
Le “vite che non sono la mia” permettono allo scrittore di evadere da se stesso, anche quando quest'evasione assume l'aspetto di un testo edificante, magari politicamente o socialmente impegnato. Questa loscaggine morale mi sembra accompagnare costantemente la scrittura di Carrère, ed è forse la più torbida tra le ragioni del suo successo. Quando ne Il regno (2014) ci mostra la sua identificazione maniacale con Luca, l'evangelista, tocca uno dei punti più alti e allo stesso tempo più bassi del desiderio di autoevasione e di autotradimento che ogni suo libro pare contemplare (il tradimento è d'altronde un topos piuttosto ossessivo nella sua opera).
Un accenno alla dimensione controfattuale della vita morale cristiana è anche presente nel saggio sull'ucronia dove si osserva che “pentirsi equivale a voler modificare il passato” e che “un concetto simile è anche nel mistero cristiano della confessione”. La conversione al cristianesimo di Carrère raccontata ne Il regno sarebbe la declinazione teologica della sua personale ucronia
Lascio fuori da questa rassegna alcune opere che, credo, potrebbe rientrarci a costo di qualche forzatura. Cito rapidamente le polemiche seguite a Yoga (2020): libro bruttino, dove il narcisismo dell'autore esaurisce la sua forza euristica e mitopoietica. Dopo la pubblicazione di Yoga la ex-moglie di Carrère ha sentito il bisogno di smascherare qualche impostura, qualche momento in cui la fantasia dell'ex marito ha preso (un po' troppo) il sopravvento sulla realtà, in barba alle sue ripetute dichiarazioni di sincerità. Senza lo specchio degli altri a Carrère non è forse restato che comportarsi come il protagonista de L'avversario, inventandosi un passato che gli faceva comodo, che lo salvava dall'imbarazzo di essere se stesso, e spacciandolo per vero.
Non so se tutta la letteratura di finzione possa definirsi come il prodotto di un'insofferenza al reale, e della volontà eccitata di un io che pretende di ricreare il mondo come lo preferisce. È un'ipotesi affascinante, ma non verificabile. Di certo la letteratura di Carrère si porta dietro questo pensante fardello. Sarebbe anche interessante capire quanto il successo dell'autofinzione, e quindi dello scrittore francese, sia stato determinato dalla capacità di manipolare il mondo e la Storia che lo sviluppo tecnologico oggi sembra offrirci, come se fossimo tutti vittime dello stesso senso di impotenza dell'ucronista, e i fake dell'intelligenza artificale la nostra opera di finzione collettiva.
Di certo, leggendo il saggio sull'ucronia di Carrère, non si può che restare ammirati di fronte a una personalità artistica così compiuta, capace già a vent'anni di anticipare i temi e le ossessioni che lo avrebbero accompagnato per una vita. Allo stesso tempo si guarda con sconcerto al sardonico destino di chi, raccontando in ogni sua opera questa intima rivolta, quella di non voler essere se stesso, alla fine dei conti lo è sempre stato, e fin dal principio, in una maniera così inesorabile.
La prima neve imbianca il monte Fuji di solito a inizio ottobre. Quest'anno, però, non è ancora arrivata. Non era mai successo che tardasse così tanto (almeno da 130 anni, da quando sono iniziate le rilevazioni).
L'anno scorso, per esempio, la neve era arrivata il 5 ottobre.
Il Giappone viene da un'estate record: le temperatura tra giugno e agosto sono state di 1,76°C più alte della media.
Mentre scriviamo, invece, dall'altra parte del mondo, in Spagna, alcune forti alluvioni nelle zone di Valencia e Castiglia-La Mancia hanno causato più di 70 morti.
Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 422,57 ppm (parti per milione) di CO2.